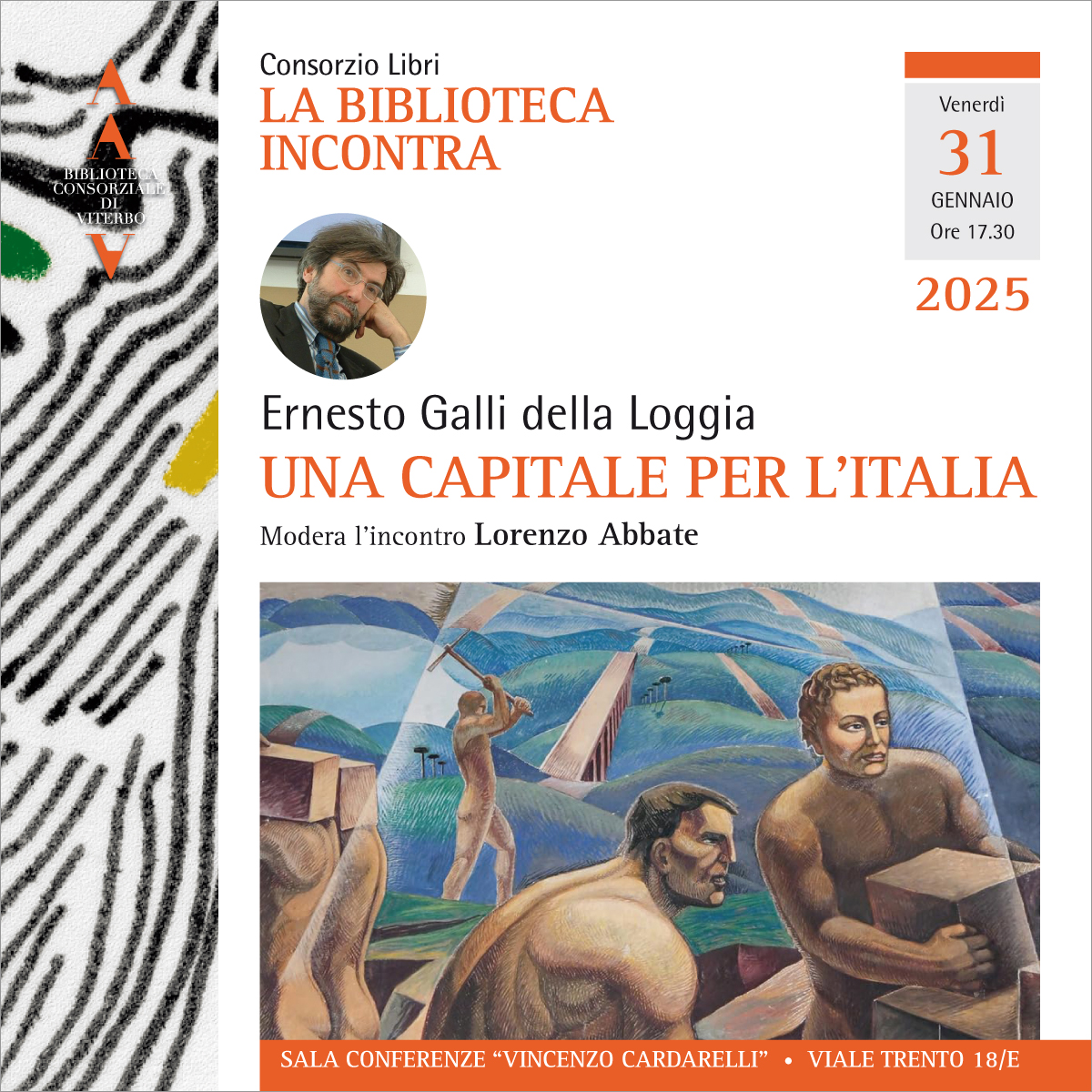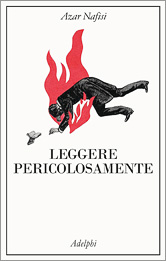Don Paolo Alliata a ‘La Biblioteca incontra’
venerdì 7 febbraio alle 17.30, per la nostra rassegna “La Biblioteca incontra”, avremo ospite don Paolo Alliata che presenterà il suo libro L’amore fa i miracoli (Ponte alle Grazie) in dialogo con il commissario straordinario Paolo Pelliccia.
Ha scritto e messo in scena per bambini e ragazzi testi teatrali sulla Bibbia (E Dio disse: “Su il sipario!”, ed. Centro Ambrosiano; “Io a Gesù bambino non ci credo mica!”, illustrato da Carla Manea, Valentina Edizioni – Centro Ambrosiano, entrambi usciti nel 2013). Per Ponte alle Grazie ha pubblicato: Dove Dio respira di nascosto (2018), C’era come un fuoco ardente (2019), Gesù predicava ai bradipi (2021).
Dal 2019 al 2024 è stato responsabile del Servizio per l’Apostolato Biblico della Diocesi di Milano, di cui è collaboratore. Dal 2022 è rettore del liceo Montini di Milano.
IL LIBRO
L’amore di Romain Gary è memoria e resistenza, nel volo degli aquiloni che inseguono l’azzurro. L’amore che scalda il cuore del professor Stoner è un sonetto di Shakespeare che schiude la porta sull’eterno. L’amore di Kundera oscilla tra leggerezza e pesantezza, vulnerabilità e compassione: è la voce bambina che canta. L’amore che aleggia nella resurrezione secondo Tolstoj è metamorfosi, grazia, primavera che arriva anche in città. L’amore, per Steinbeck, è profezia, preghiera in movimento, marcia collettiva verso la libertà. L’amore che sostiene C. S. Lewis è pianto che volge in letizia, legame che scavalca la morte, fede.
L’amore è quella forza che ci spinge a tuffarci nelle cose così come sono. Che ci rende vivi, non nelle aspettative, ma nella nostalgia di infinito, un infinito tanto più potente quanto incolmabile.
Con una prefazione di Isabella Guanzini.